‘Mi sono sentito un altro: avrei potuto reagire, come al solito, in modo veemente fino all’eccesso come accade a volte, ma mi sono detto: “Va bene. Sia pure come volete voi: aspettiamo e poi vedremo”. E così ho fatto. Per me è una novità sconvolgente: per la prima volta avevo veramente in mano la situazione e senza nessuno sforzo. Ho subito pensato a quello che ci diciamo qui’
Qui, è il mio studio di psicoanalista. A parlare così è un signore, persona che vedo per motivi professionali, che parla di una scoperta che ha appena fatto su se stesso, con stupore e anche con un certo piacere.
La sua narrazione prosegue poi precisando meglio l’accaduto: la cosa si sarebbe probabilmente svolta in modo completamente diverso fino a poco tempo prima, perché questa persona, che si sente immediatamente aggredita anche solo quando qualcuno si permette di manifestare un’opinione diversa dalla sua, tendeva a reagire impulsivamente, quasi confondendo il disaccordo con un attacco personale, un tentativo di offesa fino all’umiliazione.
Questa volta non è stato così.
Prosegue: “Mi pareva per la prima volta di vedere il mondo in modo diverso, direi tridimensionale. Come se vi fosse uno sfondo su cui si muovevano le persone con le quali mi trovavo in quel momento, persone vere, che certamente esistevano ed erano altrettanto certamente diverse da me. Ma esistevo anch’io e mi sentivo tranquillo”.
Sviluppi personali per non reagire in modo veemente
La situazione descritta può sembrare in fondo abbastanza banale: un tizio piuttosto litigioso riesce a trattenersi e per una volta si scopre abbastanza saggio.
A me, invece, viene in mente che il racconto di questa persona permette di cogliere un aspetto interessante della nostra condizione umana, presa fra la voglia di libertà totale e i limiti che la vita in comune ci pone continuamente.
Ho pensato al suo discorso come a qualcosa che potremmo considerare una specie di filo teso fra due estremi che, seguendo il pensiero di Ivan Illich, un autore ormai un poco dimenticato, si potrebbe enunciare in questo modo:” La loro (degli esseri umani) sopravvivenza umana dipende dalla capacità degli interessati di imparare, presto, da loro stessi, quello che possono non fare e quello che non possono fare”. Una misura, chiamiamola così, che non si impara sui libri.

Imparare a distinguere tra “quello che possiamo non fare” e “quello che non possiamo fare”
Dunque, a un estremo, da un lato, vi è la proibizione, il “non puoi…”, per intenderci quella cosa che la società chiama regola o legge, che si impone a ognuno come condizione per poter fare parte di qualsiasi gruppo. Tutti sappiamo che non può esistere alcun gruppo sociale se manca un insieme anche minimo di regole come condizione per farne parte. In fondo è la condizione stessa per l’esistenza del singolo individuo: tutti abbiamo bisogno di appartenere, di riconoscimenti quali solo un gruppo di individui come noi stessi ci può fornire.
Per far parte di un gruppo dobbiamo però pagare un prezzo: è l’eterno conflitto fra la natura e la cultura.

All’altra estremità vi è invece qualcosa di molto diverso anche se certamente si tratta ancora di una regola. La differenza consiste nel fatto che questa volta la persona che parla lo fa da protagonista, non solo come soggetto che subisce passivamente un ordine imposto, proibizione o obbligo.
In fondo, se esistesse solo la prima possibilità, la proibizione che ci viene più o meno minacciosamente imposta sotto pena di conseguenze negative, la nostra condizione di vita sarebbe ben misera, sottoposta al timore di conseguenze sgradevoli, di una punizione incombente e anzi addirittura governata da un principio negativo assoluto. Saremmo un poco degli eterni bambini ai quali si ingiunge di “stare fermi”, come si dice appunto a volte ai bambini quando se ne accetta male la vivacità un poco tumultuosa e proprio per questo, in effetti, a volte fastidiosa.
Le regole e la legge, sopra di noi
Qualcuno ricorda forse un film di Ingmar Bergman intitolato “Il settimo sigillo” in cui si racconta la vicenda del cavaliere Antonius Block al ritorno nella sua terra natia, dove infierisce la peste, dopo avere partecipato a una crociata.
Un predicatore si aggira per quelle contrade e con grande strepito va gridando rivolto a tutti e a ciascuno il suo minaccioso “pentitevi!”: per lui, la peste è la giusta punizione del Cielo a causa della malvagità degli esseri umani.
Una storia vecchia quanto l’umanità.
Certo la malvagità degli uomini esiste, ma oggi in genere consideriamo il fatto che essa possa causare la malattia come una visione piuttosto ingenua: se bere o fumare smodatamente, senza misura appunto, non è il modo migliore per proteggere la propria salute, i rapporti fra peccato e malattia sono comunque piuttosto labili anche se non completamente inesistenti.
Occorrerebbe poi precisare cosa si intenda per peccato e qui le cose certamente si complicherebbero.
Un poco di chiarezza, quando possibile, è sempre di aiuto e da questo punto di vista è bene ricordare che quello che noi chiamiamo regola o legge, all’origine emana da un’istanza personalizzata, qualcuno in carne e ossa che rappresenta la necessità di un certo ordine, sin dalla prima infanzia quando ci viene posto qualche limite per i motivi più svariati.
Questo qualcuno, chiunque esso sia, ha in genere delle ragioni per farlo, fossero anche ragioni di pura prepotenza, di arbitrio personale come può accadere alle volte e quindi, fatalmente, le regole esprimono sempre la presenza di un’istanza che si impone e che verrà poi rappresentata in vari modi, secondo varie liturgie: c’è il commissario di polizia e c’è il sindaco o il presidente di questa o quella organizzazione.
Questa istanza esprime in definitiva sempre una volontà che ha delle ragioni, quelle di qualcuno che si presenta o si presenterebbe dicendo pressappoco: “io voglio (oppure non voglio) che…” e che ha l’autorevolezza e l’autorità, ossia la forza, per farlo.
Nei miti che popolano la nostra storia umana, sempre un intervento di questo tipo, divino in genere, quando arriva riesce a trasformare il disordine, il caos, in ordine, in cosmo: ordine cosmico. Per esempio, Zeus (o Giove) punisce l’eccesso, la frenesia dell’orgoglio smisurato che pervade tanta parte di noi umani e che genera confusione e disagio.
La prepotente presenza dell’io
Non ne sono certo allora, ma non mi stupirei se la parola più usata da noi fosse: “io”. Qualcuno che ne sapesse qualcosa di più sarebbe benvenuto.
La parola “io”, un pronome secondo la grammatica (che impariamo a scuola dove ci vengono date le regole di quella prima lingua straniera che è la nostra lingua “materna”), è il modo in cui ognuno di noi indica se stesso/a come attore della vita oppure è il modo in cui ci presentiamo agli altri dicendo per esempio: io sono la tale o il tale.
Anche questi altri a cui ci rivolgiamo sono a loro volta degli “io”, ma dal nostro punto vista essi si indicano in un altro modo, con un altro pronome: “tu”.
Dunque, “tu” è un altro “io”, ma non quello stesso che “io” nomina quando parla di sé. Questa molteplicità ha la sua importanza dal punto di vista che ci interessa: come dire che la regola può variare.
Se infatti all’origine essa viene sempre da qualcuno, da un “io” possiamo dire, questo pronome può designare, però, persone molto diverse fra loro, accomunate eventualmente solo dall’intenzione di porre regole, di mettere freni che regolino i rapporti.
In genere poi ognuno di noi è abbastanza persuaso che le sue regole siano le migliori possibili e anzi quando la realtà ci smentisce, facilmente entriamo in polemica con essa.
Credo che nessuno possa negare che al fondo di ognuno di noi vi sia un resto, più o meno corposo, di convinzione che il mondo funzionerebbe molto meglio se fosse come dice “io”(Nessun errore di ortografia: io “dice” si riferisce a un io che dice delle cose).
Comunque: poiché gli “io” sono tanti, occorre mediare e di questa mediazione dovrebbe occuparsi quell’arte che va sotto il nome di “politica”. Qualche volta può anche accadere.

E’ ancora l’io a combattere contro le delusioni
Quando diciamo “io”, ci riferiamo dunque a un aspetto di noi stessi, quello che, almeno in teoria, dovrebbe dirigere la nostra vita o almeno quello a cui la affidiamo e che cerca di farlo. Ci riferiamo inoltre a un nocciolo razionale che sa di non dover pretendere troppo dalla vita sotto pena altrimenti di incorrere in un eccesso di delusioni.
È importante che le cose stiano in questo modo perché altrimenti rischiamo di ritrovarci in una situazione dove le cose sono dirette dalle passioni del singolo e queste, si sa, non solo non conoscono limiti, ma in più tollerano difficilmente gli ostacoli, come mostra il signore di cui all’inizio.
Da quanto precede discende una doppia conseguenza: le regole ci devono essere ma, per fortuna esse variano a seconda dei tempi e dei luoghi.
Queste precisazioni che a prima vista potrebbero apparire complicate (e in parte lo sono certamente), sono necessarie per capire la condizione richiesta per godere di una certa libertà rispetto alle regole stesse, per non esserne schiacciati come schiavi.
Detto in altri termini: se anche è vero che le regole ci limitano e che nessuno può farne a meno (anche se questa possibilità ha sempre sedotto molte persone e molte continua a sedurne), questo non significa che siamo destinati necessariamente a esserne solo sudditi passivi.
Le regole e l’autonomia
Il sistema delle leggi, delle regole, contiene sempre una quota di libertà. Sta a noi scoprirla per poterne usufruire, come è riuscito a fare il signore di cui dicevo all’inizio. In breve, essa risiede nella capacità che “io”, cioè ognuno di noi quando nomina se stesso/a, faccia della necessità delle regole una condizione della propria vita, che impari a fare a meno di qualcosa non solo per obbligo ma anche per scelta.
Detto altrimenti: una certa disciplina aiuta a vivere in libertà. Se poi questa disciplina corrisponde a un minimo di austerità interiore, forse le cose vanno ancora meglio.
È abbastanza normale che la sola parola “disciplina”, susciti oggi una certa diffidenza. Accade in genere per almeno due motivi: da un lato si ritiene che essa chiami in causa l’autorità e che questa sia necessariamente autoritaria, di conseguenza si tende a confondere la disciplina con l’imposizione che viene da fuori, in una visione della vita e della realtà dominate dalla forza dell’obbligo o almeno dal rischio di essa. Non è affatto così o almeno non sempre e in ogni caso non nella situazione di cui tratto. Mi ripeto: è bene che ci guardiamo dalla tendenza a pretendere troppo dalla vita. Ne va della nostra salute mentale e non solo.
Come dare un senso alla propria vita
Tutti noi abbiamo bisogno che la nostra vita abbia un senso. Certamente sarebbe meglio che riuscissimo a darcelo personalmente, che non ce lo facessimo imporre dall’esterno, come una forzatura oppure anche come una lusinga, come mera pubblicità.
È capitato certamente a tutti di sentire qualche frase pronunciata da una voce minacciosa oppure suadente che recita più o meno: “piegati, altrimenti vedrai!”, ma anche: “questo o quello e ti cambierà la vita ”. Può anche darsi per quanto, personalmente, mi pare che sia ben povera una vita che si lasciasse cambiare da un oggetto, da una cosa solo perché essa ci dà una piccola quota di piacere.
E allora?
Si potrebbe anche dire: se ubbidire può essere utile e perfino comodo, se il timore della punizione può essere un freno utile per iniziare a vivere, il fatto di riuscire ad avere in sé una misura personale è forse la soluzione migliore perché assegna al singolo, a ognuno di noi, il potere di regolare se stesso/a secondo criteri che non sono di timore o di utilità, o almeno non solo, ma esprimono l’intenzione di dare un senso alla propria vita invece di trascorrerla, come può accadere, nella pretesa che tutte le nostre attese siano soddisfatte.
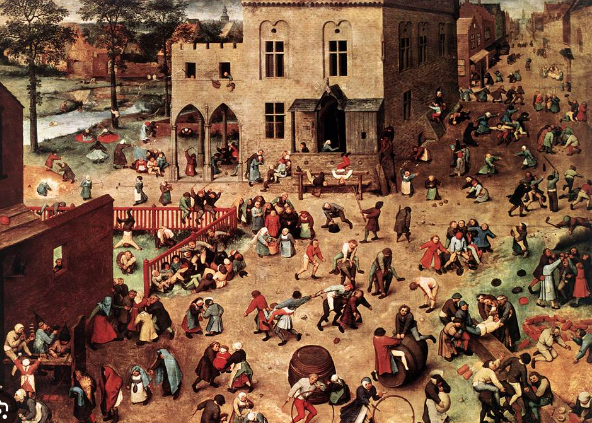
Un’idea (come un’altra)
Ogni volta che mi sorge un’idea, che mi pare di averne una, sento la voce di Paolo Conte che mi ammonisce:”….è un’idea come un’altra…”. In realtà, nella sua canzone, lui si riferisce a Genova, appunto un’idea come un’altra.
L’idea che mi è sorta consiste in questo: per dare un senso alla nostra vita, perché essa abbia un senso, forse occorre riuscire a porsi nella condizione di decidere ossia di riuscire a tagliare via qualcosa (decidere ha a che fare con il tagliare), di accettare che qualcosa venga meno, di privarcene volontariamente, ossia di accettare di poter vivere un senso di mancanza, in fondo un dispiacere.
Non esigere troppo è anche accettare “che non…”, anche con dispiacere.
Meglio, ripeto, se siamo noi in grado di farlo volontariamente piuttosto che subirlo. Molto meglio.
E allora ecco l’altro capo del filo di cui dicevo e che si potrebbe enunciare esattamente come faceva la persona di cui dicevo all’inizio sulla scia di Ivan Illich: “Io posso anche non…..”
Tutti noi possiamo anche non…. Tutti noi, ciascuno di noi può dire a se stesso/a: “Posso non farlo……( non dirlo, non sceglierlo, non volerlo o altro ancora)”.
Ripeto per ribadire: “possiamo non” è un grande potere che ci concediamo.
“Posso non” vuole dire che colui o colei che disciplina la mia posizione, che guida la mia vita è “io”. Non la lascio decidere dall’esterno, dal singolo o anche dal complesso sociale che mi sorveglia, che mi osserva per valutarmi o per sedurmi, ma lo faccio in modo autonomo, schierandomi dalla parte di chi prende una determinata posizione negandosi l’onnipotenza del “faccio quello che voglio perché voglio tutto”.
“Questo posso anche non farlo” significa esattamente: “non posso tutto e non solo lo so ma anche voglio che sia così”.
Quello che indico come “Io” segue allora una sua disciplina interiore che si è dato/a di propria iniziativa, ossia prende su di sé la responsabilità del modo di condurre la propria esistenza. Con tutte le conseguenze del caso.
Certo questa capacità non è la manna, non piove dal cielo, ma si costruisce poco alla volta. In primo luogo, essa ci deriva in genere dall’esempio: dapprima questo è fornito dalle parole ma poi, e anche abbastanza presto, prima dei dieci anni, soprattutto dal comportamento di chi, per ognuno di noi, rappresenta qualcosa di significativo.
In genere si tratta degli adulti, i giganti delle fiabe, quindi in primo luogo i genitori, e poi le figure dotate, per evidenti ragioni cronologiche, di carisma, autorevolezza e autorità, e per questo motivo capaci di favorire dei processi di identificazione verso qualcosa che tende, e a volta anche riesce, a darci un regime interiore di dominio sulle passioni.
È molto auspicabile che fossero in grado di farlo, almeno un poco, gli insegnanti e in genere i maestri, tutti coloro che svolgono un’attività di tipo educativo, formativo.
Occorre precisare peraltro che qualsiasi atteggiamento, anche negativo, può assumere un valore di esempio. Fa parte della nostra condizione umana.
Educare le passioni e governarle per non esserne governati (non troppo almeno, perché può sempre accadere che una passione, per esempio un innamoramento, ci prenda per un tempo più o meno breve o anche lungo), non vuol dire irrigidirsi in un modo di vivere freddo, distaccato, distante, fatto solo di controllo su di sé, di ragionamenti, ma, invece, è la capacità di prendere distanza da quegli impulsi che ci porterebbero nella direzione del “fare quello che voglio”, fare della nostra volontà la regola: invece posso fare della regola qualcosa che la mia volontà riconosce come una necessità per vivere ossia per dare un senso alla mia vita. Farla mia.
Per certi aspetti risveglia anche un’idea di normalità, anche questa un’idea come un’altra, ma che suscita in genere una certa diffidenza. Uno dei motivi principali è che essa viene considerata in termini di valore, di giudizio.
In realtà vi è anche almeno un altro modo, più neutro, di considerare la normalità, un modo statistico, di cifre, di fatti dunque, di distribuzione di eventi lungo una curva. Una questione matematica che non si dovrebbe prestare a contestazioni pur potendo suscitare qualche malumore.
In questa prospettiva, l’idea di normalità ha qualche consistenza perché se, come dicevo, le norme variano, il riferimento alla norma è costante come necessità razionale, riferibile appunto a quell’io che dovrebbe, almeno nelle intenzioni, governare l’esistenza di ciascuno.
Per tornare all’esempio del predicatore del film di Bergman, è evidente che questo signore sta dando sfogo a certe sue passioni crudeli, inveendo contro gli altri e soddisfacendole in questo modo. In più però, egli giustifica se stesso: attribuisce agli altri una malvagità tutta da dimostrare, ma a noi restano ben pochi dubbi che il vero malvagio sia lui stesso.
Qui sta il punto: la disciplina cui alludevo è quella tale forza interiore che permette di prendere in mano le cose, non di subirle, fosse pure in nome di un’istanza nobile e superiore, ma di immedesimarsi in questa istanza, di diventare lei stessa perché la sentiamo in noi, la rendiamo parte di noi.
E allora essa ci parla non solo dando ordini, ma anche guidandoci ci rassicura e quindi ci protegge: ”Posso anche non….”: non è un’imposizione da fuori, una minaccia, una lusinga, ma una scelta in cui sono quella/o che ha in mano le cose.
Questo è il punto più alto al quale possiamo arrivare come esseri umani.
Disprezzare questa disciplina, questa capacità di guidare se stessi come accade a volte, oppure anche solo rinunciarvi per conseguire un beneficio immediato è possibile naturalmente, ma non è esente da pericoli. Non si tratta solo del rischio di retrocedere alla legge della giungla o al mondo delle fiere dove vige la legge del più forte.
Come esseri umani, anzi proprio in quanto tali, umanizzandoci ci siamo anche indeboliti in un certo modo: abbiamo perso l’antica sapienza dell’istinto, quella che guida l’animale nella maniera più opportuna a seconda delle circostanze, per cui la gazzella non attaccherà mai il leone.
Questa sapienza istintiva noi esseri umani non la possediamo più: basti pensare a come possiamo metterci in pericolo nei modi più “spensierati”. E anche mettere in pericolo altri con i nostri comportamenti.
Rinunciare a una certa disciplina, a una certa sobrietà interiore non rischia dunque solo di retrocederci a un livello un poco animalesco, ma anche qualcosa di peggio, qualcosa che noi indichiamo a volte con una parola che si usa per esprimere un certo disprezzo per il mondo animale con cui non si vorrebbe mai avere a che fare.
Voglio dire che, più duramente e drammaticamente, possiamo anche diventare “bestioline”.


